Il Bel Paese in carne e ossa
 I ragazzi e il giorno dell’unità
I ragazzi e il giorno dell’unità
Si avvicinava il 17 e, essendo per la scuola giorno di vacanza, si stava per consumare una delle dimostrazioni di autoreferenzialità (in gergo calcistico: autogol) della scuola. Un giorno in cui si è “pieni” di una storia, si riduceva, me connivente, a un giorno di “vuoto” (vacatio, vacanza); un giorno di appartenenza a un giorno di in-appartenenza. Solo chi appartiene a qualcuno si appartiene e desidera che qualcuno gli appartenga. Questa è l’origine di ogni genuina pietas (la cura verso coloro ai quali apparteniamo): chi non cura la sua appartenenza diventa “spietato” (senza pietà) verso i suoi stessi cari. Chi non appartiene a una famiglia, a una città, a una patria non si appartiene e non riesce ad accogliere, perché non sa cosa dare. Può solo prendere e pretendere e, se non ci riesce, recrimina o fugge.
Ma Edoardo, uno dei miei alunni, mi ha risvegliato, come accade quando mi adagio su soluzioni comode: «Prof per i 150 anni dovremmo fare una lezione speciale». Farò lezione sul testo di Petrarca «Italia mia, benché il parlar sia indarno». Il poeta – già allora e più di oggi – la scorge vulnerata nel suo «bel corpo» e chiede a Dio: «che la pietà che Ti condusse in terra / Ti volga al Tuo diletto almo paese». Petrarca chiede rinnovata pietà e i miei ragazzi negli scritti che ho chiesto loro per l’occasione parlano di «cura». Proprio il dramma dell’in-appartenenza spinge dei liceali a parlare dell’Italia in modo che non mi aspettavo: il coraggio di rimanere anziché fuggire, per prendersi «cura» di quel «bel corpo». La «pietà» invocata da Petrarca e la «cura» indicata dai ragazzi sono la stessa cosa.
Ancora una volta passato e futuro si stringono e mi costringono a rinascere, anche in mezzo al disfattismo dilagante. Per poter essere “originali” bisogna avere delle origini: solo chi appartiene può appartenersi e scoprirsi. Alcuni dei miei ragazzi sentono il dramma dell’in-appartenenza e invece di starsene a guardare, paralizzati dalla malinconia stanca degli adulti, propongono la terapia: prendersi cura dell’Italia. Non vogliono esserne figli disamorati, ma padri innamorati. Ne avranno la possibilità solo attraverso il lavoro, teso a costruire non solo il bene privato, ma soprattuto il bene comune: quel lavoro che è servizio e che, da professore, vivo, provando a prendermi cura dei ragazzi, il mio Bel Paese in carne e ossa.
Mi è così tornato in mente che la letteratura che insegno comincia con il patrono (padre e protettore), di questa nostra terra: Francesco. Un vero sognatore, innamorato di Dio, della realtà e degli uomini. Di padre umbro e madre straniera, il santo e poeta inventa il primo testo che accomuna tutti gli italiani: un canto di lode che, attraverso il sole, le stelle, il vento, l’acqua, il fuoco, la terra, gli uomini e persino la morte, resi fratelli e sorelle, si leva fino al Padre di tutta la realtà. Lo compone nella sua lingua madre, la lingua che la sua terra gli ha insegnato, un volgare di marca umbra purificato da eccessivi dialettalismi, capace di raggiungere ogni tipo di pubblico. Un pubblico che ancora non si sapeva popolo, ma che quel canto in versi ritmati, impreziosito da moduli retorici letterari e da elementi linguistici latineggianti, strinse tutti al calore dello sguardo di un unico Padre. Così Francesco inventava l’Italia.
A questo giovane intrepido cavaliere e giullare innamorato, attraverso il suo Cantico, chiederò il 17 il dono della pietà/cura di un Paese che lui ha sognato. Solo se, come Francesco, avremo il coraggio di dimenticarci del nostro orticello e di rimettere al centro della nostra esistenza il bene comune, questo Paese potrà ritrovare sé stesso: le sue origini e la sua originalità, senza accontentarsi di miti di fondazione che suscitano comode e passeggere emozioni, ma non faticose, quotidiane, esaltanti trasformazioni.

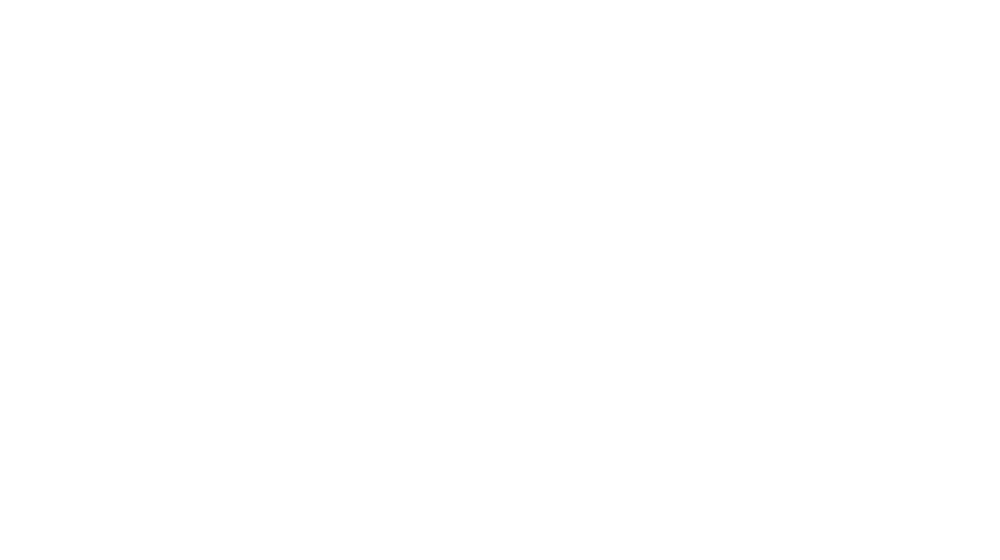
…leggere questi articoli ed avere la consapevolezza che i ragazzi li apprezzano ed hanno desiderio di sapere, di riscoprirsi,(molto di più degli adulti),mi rendono fiera, non tanto del paese di origine ma dell’origine dell’umanità
Come sempre, parole di saggezza…
Complimenti per l’editoriale in prima pagina!!!
L’invito a prendersi cura del nostro bel paese è un insegnamento che i nostri giovani, spesso più coraggiosi e vivi di noi ci donano in occasione di questa festa. E il richiamo al Cantico di S. Francesco mi ricorda come considerare ogni cosa segno dell’amore di Dio sia soprattutto un invito al bene, in una realtà che vogliamo addomesticare a nostra misura.
Bravo, Alessandro: un articolo vero, profondo e originale! Grazie!
è bello vedere ragazzi come me che si interessano al bene dell’Italia purtroppo non tutti la pensano così ed è per questo che oggi ci ritroviamo in questa situazione..complimenti davvero un articolo stupendo e ricco di significato..
unita nella diversità, diversa nell’unità…
Caro Alessandro, non sai quanto attendessi le parole che hai scritto nel tuo ultimo articolo su Avvenire. Sono venuta sul tuo blog questa sera per cercare, ancora una volta, una voce di speranza, che mi testimoniasse che è possibile sperare oggi, e farlo anche con una valida ragione. A casa sento solo persone che si lamentano del presente, attribuendo tutta la colpa dei mali odierni alla politica. Ma io ho bisogno di soprattutto di sapere dov’è il bene per aggrapparmici e vivere alla grande.
sono un tuo collega. ho messo insieme un gruppo di ragazzi e amici in un’associazione che fa teatro. per il 150° debuttiamo con uno spettacolo per ragazzi che si chiama “calzini d’italia”. manco a dirlo, lo spettacolo ha tre grandi figure come protagonisti: francesco, dante e colombo. prendiamoci cura di questa splendida eterna ragazza. buon lavoro.
Professore, nel generale apprezzamento per la sua missione di insegnamento de “la cura”, me lo fa un favore personale? La prossima volta mi scrive almeno una volta la parola “internazionalismo” e se proprio ha tempo una locuzione simile a “pur nella reale complessità della situazione e delle reali difficoltà”? Una concessiva che ci conceda di riflettere con il dovuto realismo.
La ringrazio molto.
Mi sembra che il finale ne parli chiaramente…
Mi sembra di no.
Lei, se mi permette, fa di una serie di concetti condivisibili un gran pasticcio. Si chieda quanti ragazzi accaniti, qualificati, tenaci vorrebbero tornare a casa e non possono. Non vorrebbero partire e sono costretti. Pietas, vero? Mentre lei è là, noi siamo qua, costretti a una scelta che non vorremmo, in perenne oscillazione fra imperativi di rispetto per se stessi e per la propria preparazione e occasionali colpi di reni della volontà per dirsi di resistere, che tutto questo non è giusto. Ce la dà lei la sponda di attracco?
Belle le poesie, qui però in ballo c’è la vita. Nostra. Il giudizio (negativo) di valore sulle persone in difficoltà, in ogni caso, è cosa che deve finire.Grazie per l’attenzione.
Mi scusi L.T., ma non capisco. Cosa c’entra tutto questo con il mio articolo, che in poche battute si limita a raccontare cosa io festeggio oggi e come i miei ragazzi mi hanno aiutato a ricordarmene. Non era un articolo in cui affrontare quanto lei mi suggerisce. Io la sponda d’attracco non posso darla, mica sono il salvatore di niente e nessuno. So solo che sto in classe a mille euro al mese per scelta. Questo è l’attracco che io offro. Sono nato a Palermo, mi sono trasferito a Roma a 18 anni, ne ho vissuti 11 lì, da 4 sto a Milano e tutto questo in cerca di lavoro. Quest’anno ho avuto il mio primo contratto a tempo indeterminato, a 33 anni. Io non parlo di poesie, ma di vita. Le poesie ne sono solo il precipitato. La poesia di cui parlo è quella di un uomo (Francesco) che ci ha lasciato la vita per cambiare questo paese, non faceva poesie per fare poesie. Le auguro ogni fortuna e mi spiace sentire tanta fatica e rabbia dietro le sue parole.
Professore, io non dubito delle sue buone intenzioni, del vissuto e della cura (è una parola importante, è una responsabilità) che ci mette.
Ma colgo come uno schiaffo in faccia di alcuni passaggi, che toccano punti essenziali:
“Solo chi appartiene a qualcuno si appartiene e desidera che qualcuno gli appartenga. Questa è l’origine di ogni genuina pietas (la cura verso coloro ai quali apparteniamo): chi non cura la sua appartenenza diventa “spietato” (senza pietà) verso i suoi stessi cari. Chi non appartiene a una famiglia, a una città, a una patria non si appartiene e non riesce ad accogliere, perché non sa cosa dare. Può solo prendere e pretendere e, se non ci riesce, recrimina o fugge”.
“Ancora una volta passato e futuro si stringono e mi costringono a rinascere, anche in mezzo al disfattismo dilagante. Per poter essere “originali” bisogna avere delle origini: solo chi appartiene può appartenersi e scoprirsi”.
Lei crede che chi si allontana (chi sceglie, pur non volendo, di ritagliarsi possibilità di vita in un altrove rispettoso dei diritti fondamentali) dimentichi le proprie origini? Pensa che non resti teso e tagliente il filo con ciò che si lascia? Pensa davvero che oltreconfine incontrerebbe sguardi spietati? Sa cosa vedo io? Persone che si stringono, che strappano il dovuto dai propri sforzi, che soffrono. Che vorrebbero tornare, mentre la loro riva (ingrata! una riva ingrata!) si allontana. E La Cura, la pietas che lei chiama in causa, suggerirebbe un atto di comprensione.
Se non con i fatti, che sia con la parola. E se la parola rischia di essere mal spesa, di attribuire demeriti, beh. Non resta che il silenzio. Della mano “che ha cura” si devono vedere le vene dei polsi, non le nocche.
Quindi io la prego. Non parliamo più di “disfattismo dilagante”, vedo con orrore prendere forma una retorica acchiappacitrulli. Insegnate ai ragazzi a scandagliare la realtà delle cose, non pretendete di insegnare loro il sorriso nella tempesta: la tempesta esiste, arriverà anche per loro e ne usciranno spettinati e confusi più di quello che non sono già. Ne farete degli inconsapevoli, degli adepti dell’ “ha da passa a’nuttata”, giullari di corte che suonano il piffero davanti agli affamati.
La ringrazio dell’augurio, ma non mi interessa la fortuna. Con rabbia e ostinazione voglio che il mio paese recuperi il giusto sguardo, e un punto di equilibrio che chiami le cose con il loro nome. Noi non dobbiamo rinascere: noi siamo già nati. Siamo adulti in impasse, costretti alla miopia pur avendo ottimi occhi, e questo a Francesco non sarebbe piaciuto.
L’augurio che le rivolgo io è di una ripensata e matura unità di intenti. Allora si parlerà meglio di “bene comune”.
Cara L.T. continua a fraintendere quello che ho scritto. Io mi limito a descrivere il fatto che chi non sa di appartenere ad un bene comune, il proprio Paese, non se ne prende cura. Costoro recriminano o fuggono. Mi riferisco a quanti, già nel mondo del lavoro, coltivano il loro orticello fregandosene del bene comune. Per questo addito nel lavoro delle nuove generazioni il possibile riscatto, se questo lavoro lo avranno… Ho una sorella “migrata” in USA proprio per questo, un’altra scavalcata da una raccomandata in un posto che spettava a lei… Non attribuisco demeriti a chi si allontana, ma a chi non appartiene. Mi sembra presa dalla sindrome del barone rampante, figura affascinante, ma che in fondo dall’alto degli alberi dice a chi sta sotto che è un citrullo. Stia tranquilla che in classe i miei colleghi ed io facciamo quel lavoro, o forse pensa che a 33 anni si sia così stupidi da entrare in classe per rendere stupidi i propri alunni? Se lei leggesse anche altri articoli del blog troverebbe un pensiero più ampio di quello di queste 3000 battute per un giornale, nelle quali vede o non vede molte più cose di quelle che ci sono. Se lei non vuole “rinascere” non la costringo io. Mi limito a dire che “rinasco” tutte le volte che prendo una lezione dai classici che leggo e dai miei ragazzi. In tutto questo non ho ancora capito cosa propone, perché ci troveremmo, credo, molto più vicini negli intenti che lei dice da ripensare e maturare. Sia costruttiva. Questo è già bene comune.
..eppure io dico che è attraverso lo sguardo della poesia di Francesco come di Petrarca, come di mille altri che può arrivare una unità di intenti. Questo è l’impegno che colgo dietro le parole del prof Alessandro. Il mio è un lavoro amministrativo nell’ambito informatico, quando di più lontano dalla poesia, dalla parola..eppure sento il bisogno di entrambe. Caro L.T. la vita non è solo quella burrasca che prospetti, o quantomeno non bisogna andarle incontro con un animo troppo inaridito
Sono d’accordo, gentile Elisa. Bisogna andarle incontro con animo spalancato e sacrosanta voglia di sole. A casa gli ombrellucci bucati, che tengono solo le mani impegnate.
Gentile L.T. ho quasi 50 anni e due figli..qualche ombrelluccio bucato ha attraversato i miei giorni..non pensa? Eppure concordo con il prof.
Siamo gente strana eh? 🙂
Sono d’accordo con Elisa e con il Prof 2.0 e vorrei aggiungere una piccola riflessione. Nasciamo con un bagaglio complesso che chiamiamo tradizione che ci permette di affrontare la realtà. La tradizione ci è data non per fermarci ad essa, ma per sviluppare in modo creativo quanto abbiamo ricevuto; così rinasciamo ogni giorno, forti di un passato cui apparteniamo, guardando ad un futuro che non ci appartiene ancora, che ci si può presentare ostile e pieno di obiezioni, ma che grazie ai valori e alla ricchezza che ci è stata data possiamo cambiare intervenendo con ragioni, progetti, critiche, costruttività. A volte temo ci sia difficoltà nel condividere le parole che utilizziamo. La parola è portatrice oggettiva di significato, ma la carichiamo anche del nostro significato inserendola in un contesto; per questo ho l’impressione che l’equivoco con L.T. e il Prof. si sia generato proprio sul senso di parole come origine e appartenenza. Mi piace perciò usare anche quest’altra parola, insieme alle precedenti, tradizione, perché se un uomo ha una tradizione come dato e poi la rigetta senza utilizzarla è possibile che il proprio destino prenda una piega non gradita. Essere leali con la tradizione è importante per poter decidere della propria vita: non voglio che la violenza dell’ambiente decida per me. Cito una frase di Goethe che meglio di me esprime il concetto di tradizione come esperienza fondamentale per la vita dell’individuo: ” Quel che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo.”
P.S. S. Francesco parla anche di “perfetta letizia” e nessuno vuole illudere i ragazzi a sorridere durante la tempesta: è ragionevole dir loro di ripararsi, ma forse è anche giusto insegnare loro,attraverso l’esperienza di chi quella tempesta l’ha vissuta prima, che la si può affrontare con una prospettiva diversa da quella del lamento, della rivendicazione e della rabbia. ( parlo non per sentito dire, ma per aver affrontato diverse tempeste nel mia vita di ultracinquantenne)
Gentilissimi,
se anche foste gente strana, cosa che non penso affatto, per me non sarebbe un problema.
Maria Rita: lei affronta un tema su cui ho speso diverse diotrie, leggendo Gadamer e riflettendo a fondo su diversi passaggi, fra l’altro molto contestati. Non ho in merito un’opinione compiuta come quasi in niente del resto, e non vorrei trasformare una conversazione sulla realtà di oggigiorno in una dissertazione filosofica. Resta il sospetto di una deriva conservatrice degli appelli alla tradizione, e secondo me vale la pena fermarsi a riflettere un attimo prima che la corrente ci porti via.
Professore, la pensavo sabato sera sa? Un amico ingegnere mi raccontava del pianto davanti a sua nonna alla vigilia di una partenza per l’estero, senza biglietto di ritorno. Guardi, senza pathos, era molto lucido nel descrivermi il nugolo di sensazioni. Ripensavo agli “occhi spietati”, mi è sembrato di capirlo molto a fondo, ed è finita che è venuto da piangere anche a me. Più che per tristezza, per banale senso di giustizia. Scusate il sentimentalismo, ma visti i tempi, in cui tutti ci affanniamo nel gioco partigiano degli accordi e dei disaccordi come se si trattasse di un match, sarebbe forse da ritrovarsi a questi incroci.
Gentile L.T., io leggo proprio nel senso che dice Lei lo scopo di questo blog (come di altri che seguo): la possibilità di incrociare finalmente lo sguardo con chi, almeno in parte, può immedesimarsi con noi, e perciò aiutarci a scoprire qualcosa in più su noi stessi.
Se ho ben capito leggendo i suoi commenti, di punti di contatto tra lei e D’Avenia ce n’è più d’uno (al di là dei vissuti e delle espressioni diverse). E al di là di questo, ritengo preziose soprattutto alcune sue ultime precisazioni: tradizione non può essere tradizionalismo; giustizia non può essere pietismo. E la commozione (“muoversi con, muoversi per”) penso sia ciò di cui più noi abbiamo bisogno…