Letti da rifare 10. Non farò mai l’insegnante
 «Cari professori, siete la categoria che più mi irrita. So già cosa state pensando: “i soliti adolescenti”, “questi giovani di oggi”, “non ci ascoltate mai”. Fermatevi. Capovolgete la situazione. Siamo noi ragazzi a pensare: “i soliti insegnanti”, “questi frustrati di oggi”, “non ci ascoltano mai”. La passione che trasmettete è pari a uno schiaffo. Magari alcuni professori vi hanno rovinato la vita. Posso capirlo. Perché allora non agire per contrasto? Trasmetteteci tutta la passione che avreste voluto ricevere. Guardateci negli occhi e scovate le scintille di vita e di talento. Sfidateci. Siate padri e madri. Semplicemente: siate! Cercate di cogliere la nostra individualità e diversità. Gli adolescenti non sono tutti uguali. Non sprecate energie nel tarparci le ali o dirci che non ne vale la pena, perché altrimenti penseremo che VOI non ne valete la pena. Non farò mai l’insegnante: questa è l’unica certezza che mi avete dato. La buona notizia però è che siete in tempo per cambiare e per cambiarci. Se lo farete sarete ricompensati. Noi vi seguiremo. Lo prometto». Qualche mese fa ho ricevuto questa impetuosa lettera che, al netto dei toni dettati dall’intransigenza adolescenziale, da un lato mostra il forte desiderio di maestri appassionati e affidabili da seguire senza la pretesa illusoria di poter crescere da soli, dall’altro mette il dito nella piaga della scuola: l’assenza di cura per l’unicità delle persone. Quella stessa cura che noi insegnanti fatichiamo a prestare perché, prima di tutto, non la riceviamo noi. Il fuoco che anima chi comincia con entusiasmo la professione viene puntualmente spento da un sistema che ottiene il contrario di ciò che si propone, come tradisce la sua iper-burocratizzazione, tipica delle strutture umane autoreferenziali e impersonali, in cui il tempo da dedicare alle vite viene sostituito da carte prodotte da chi in classe non entra.
«Cari professori, siete la categoria che più mi irrita. So già cosa state pensando: “i soliti adolescenti”, “questi giovani di oggi”, “non ci ascoltate mai”. Fermatevi. Capovolgete la situazione. Siamo noi ragazzi a pensare: “i soliti insegnanti”, “questi frustrati di oggi”, “non ci ascoltano mai”. La passione che trasmettete è pari a uno schiaffo. Magari alcuni professori vi hanno rovinato la vita. Posso capirlo. Perché allora non agire per contrasto? Trasmetteteci tutta la passione che avreste voluto ricevere. Guardateci negli occhi e scovate le scintille di vita e di talento. Sfidateci. Siate padri e madri. Semplicemente: siate! Cercate di cogliere la nostra individualità e diversità. Gli adolescenti non sono tutti uguali. Non sprecate energie nel tarparci le ali o dirci che non ne vale la pena, perché altrimenti penseremo che VOI non ne valete la pena. Non farò mai l’insegnante: questa è l’unica certezza che mi avete dato. La buona notizia però è che siete in tempo per cambiare e per cambiarci. Se lo farete sarete ricompensati. Noi vi seguiremo. Lo prometto». Qualche mese fa ho ricevuto questa impetuosa lettera che, al netto dei toni dettati dall’intransigenza adolescenziale, da un lato mostra il forte desiderio di maestri appassionati e affidabili da seguire senza la pretesa illusoria di poter crescere da soli, dall’altro mette il dito nella piaga della scuola: l’assenza di cura per l’unicità delle persone. Quella stessa cura che noi insegnanti fatichiamo a prestare perché, prima di tutto, non la riceviamo noi. Il fuoco che anima chi comincia con entusiasmo la professione viene puntualmente spento da un sistema che ottiene il contrario di ciò che si propone, come tradisce la sua iper-burocratizzazione, tipica delle strutture umane autoreferenziali e impersonali, in cui il tempo da dedicare alle vite viene sostituito da carte prodotte da chi in classe non entra.
Guardate la vita contenuta nella vostra mano: le linee sul palmo e le impronte digitali con le quali il vostro cellulare vi riconosce, sono le stesse che avevate a neanche un mese dal vostro concepimento. Fu osservando al microscopio questi solchi, che a metà del secolo scorso Jerome Lejeune scoprì la causa genetica della sindrome di Down. Lo scienziato amava dire che già nello zigote, la cellula frutto dell’unione di spermatozoo e ovulo, era contenuta la profezia di una vita intera: il genoma, il corredo cromosomico per metà materno e per metà paterno, equivale a un libro inedito di oltre 3 miliardi di lettere scritto nel nucleo di una cellula di 0,1 millimetri. Un messaggio, unico e irripetibile, che si sviluppa e specifica gradualmente in un essere altrettanto unico e irripetibile, la cui vita cresce solo se ne viene curata e rispettata l’originalità. L’alternativa è infatti la morte fisica o spirituale, come mostrano le parole scelte da Vasilij Grossman all’inizio del suo capolavoro, «Vita e destino», per descrivere l’uniformità dei campi di concentramento: «La ferocia disumana dell’enorme lager si esprimeva nella regolarità perfetta. Le izbe russe sono milioni, ma non possono essercene — e non ce ne sono — due perfettamente identiche. Ciò che è vivo è irripetibile. Due uomini, due cespugli di rose selvatiche, non possono essere uguali. E dove la violenza cerca di cancellare varietà e differenze, la vita si spegne».
In modo diverso scienza, letteratura e storia ci mostrano che l’esistenza è posta sotto il segno dell’unicità e qualsiasi struttura umana ignori o annulli tale segno spegne la vita: per questo conformismo e totalitarismo sono gemelli, il primo costringe a fare ciò che gli altri fanno, il secondo ciò che gli altri vogliono. Sono disumani tutti i sistemi che ostacolano la pluralità necessaria per vivere la propria libera e autentica dimensione sociale, in cui ciascuno dà agli altri quello che è e riceve dagli altri quello che non è, come accade in un’orchestra, in una squadra, perché il timbro di ogni singolo strumento o il ruolo occupato in campo sono necessari all’armonia totale. Il nostro sistema scolastico tende a ignorare e persino ostacolare l’unicità, per questo spesso produce insegnanti e alunni frustrati. Che cosa avvelena un mestiere così bello e la naturale predisposizione dell’uomo alla conoscenza? Il fatto che docente e studente vengono inseriti in una catena di montaggio da cui escono sfiniti più che finiti, perché trattati da oggetti anonimi e non da soggetti di possibilità irripetibili.
Basta correggere i compiti degli studenti per scorgere una potenziale orchestra o squadra: la loro grafia in cerca di se stessa, ora illeggibile, ora elegante, è il segno evidente di un rapporto unico con la realtà. Stanno elaborando la loro presa di posizione di fronte al mondo, possibile solo grazie alla scoperta, conoscenza, accettazione della propria unicità. Per essere originali bisogna essere originari, questo vuol dire che nel periodo di formazione è fondamentale che gli educatori per primi siano consapevoli della propria unicità. Noi insegnanti siamo direttori d’orchestra o allenatori, abbiamo a che fare con vite irripetibili a cui affidare la sinfonia o la partita. Eppure nei nostri registri mancano spazi per descrivere i talenti di un ragazzo. I consigli di classe si riducono alla condivisione di voti e fatti spiacevoli di condotta. Se un ragazzo assistesse al momento in cui parliamo di lui durante un consiglio, che cosa scoprirebbe di sé? Si sentirebbe riconosciuto, tra punti forti e deboli, come portatore unico di qualcosa di nuovo? I collegi docenti diventano spesso dibattiti burocratici più che educativi. Negli scorsi anni abbiamo dovuto seguire corsi sulla sicurezza, e mi sembra opportuno, ma io vorrei essere obbligato anche a formarmi su come si scoprono i talenti dei ragazzi, sul mondo del lavoro di oggi e di domani, per orientarli in un presente che sta subendo una trasformazione senza precedenti. Quando sento dire, da chi in classe non entra, che l’uso del cellulare in aula è un toccasana per l’apprendimento ho la conferma dell’assenza di un progetto adeguato alle esigenze reali degli studenti, a cui invece servirebbe imparare come funzionano i linguaggi di programmazione che permettono alle app di funzionare, agli algoritmi di profilarci, proprio grazie a quel cellulare. Un sistema che non valorizza i docenti si merita una scuola che spegne la vita e che, invece di affrontare il mondo, lo ignora o vi si adegua.
Per questo, oggi più che mai, a prescindere dalle forze politiche in gioco è urgente un programma trasversale di riforma dell’istruzione con obiettivi minimi non più procrastinabili, immuni da partigianerie. In Germania, dove hanno impiegato mesi per formare un governo, su una cosa tutti i partiti erano concordi: aumentare i fondi per la ricerca. Abbiamo bisogno di una riforma condivisa e affrancata dall’essere una leva politica. Da dieci anni si aspettava la revisione del contratto di chi lavora nella scuola e l’accordo raggiunto, a pochi giorni dalle recenti elezioni, prevede una quarantina di euro netti in più in busta paga: uno zuccherino elettorale per uno stipendio molto al di sotto della media europea. Dibattiamo invano sul liceo di quattro anni, quando ci sono da rivedere tutti i percorsi, asfissiati dall’impossibilità di costruire un curriculum flessibile e scegliere gli insegnanti, soprattutto in un mondo in cui è imprescindibile una preparazione che metta in comunicazione area umanistica, scientifica, economica e tecnologica. La formazione professionale diventa una giungla se non è frutto di un progetto coerente con le necessità del lavoro e del territorio. I precari sono spesso utilizzati per il sostegno per il quale non sono formati. I vincitori di cattedra sono lanciati lungo la penisola senza rispetto delle vite familiari: ho ascoltato lo sfogo di colleghe che, pur di non perdere il posto, spendevano più dello stipendio per tornare in famiglia nel fine settimana. Perché i docenti, ottenuta l’abilitazione, non possono essere chiamati dalle scuole sulla base del curriculum come accade all’università e muoversi liberamente come in tutti i sistemi europei? I fatti di cronaca recenti mostrano che l’assurda violenza, verbale e fisica, contro i professori è l’esito di una frustrazione che non potendo cambiare un sistema anonimo si scaglia sui suoi rappresentanti.
Il letto da rifare oggi è nelle parole un po’ corsare di una sedicenne contro un sistema, obsoleto e impersonale, che spegne prima i docenti e quindi i ragazzi, trattandoli come oggetti. I discorsi sul rispetto delle diversità restano slogan, se nei fatti la scuola trascura le differenze, perché non cura l’unicità. Riformare l’istruzione è necessario se vogliamo un nuovo Rinascimento italiano, ed è una responsabilità della politica, il cui compito è valorizzare e semplificare l’iniziativa dei cittadini non ingabbiarla fino ad annullarla, come accade nei sistemi totalitari e in quelli conformisti: nei primi è vietato dire che qualcosa non va, nei secondi diventa inutile persino dirlo.
Corriere della Sera, 26 marzo 2018 – Link all’articolo e ai precedenti

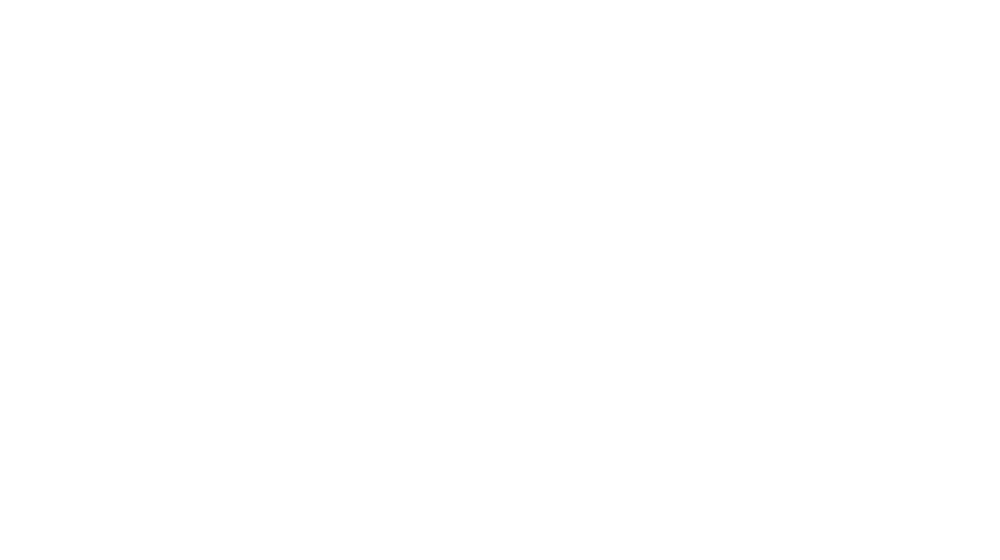
Condivido le idee di fondo dell’articolo e credo realmente alla necessità di cambiare il nostro approccio con gli studenti, l’ idea della scuola come azienda è fallimentare ha generato insulsa competizione, dimenticando che i ragazzi non sono un prodotto finito più o meno perfetto,reso tale, da un processo produttivo efficace ed efficiente. Ciò ci ha riversato in una palude burocratica e contraddittoria, si chiedono percorsi differenziati e personalizzati ma la valutazione è poi su un modello standard (invalsi) a cui bisogna attenersi ; proponiamo obiettivi educativi per promuovere la collaborazione e la condivisione tra i ragazzi e poi tra noi si è scatenata la più becera competizione e assurda burocratizzazione. So che è facile sottolineare le cose che non vanno, bisogna comunque essere propositivi e ricordarsi che la scuola è e deve essere il luogo in cui si coltiva la pianta “Umanità”.